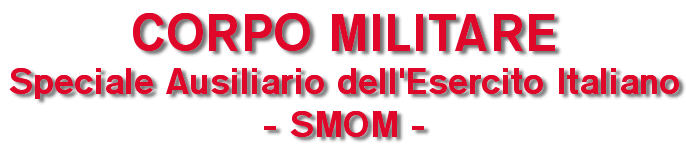
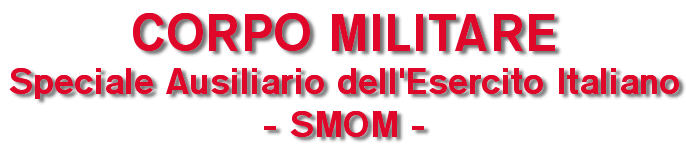


|
Il Corpo Militare è stato costituito 120 anni orsono, il 29 gennaio 1877, con il precipuo scopo di provvedere allčassistenza sanitaria dei malati e feriti in guerra . Lčatto costitutivo del Corpo fu suggellato da una Convenzione firmata dal Ministro della Guerra, Generale Ferrero, e dal Presidente dellčAssociazione dei Cavalieri di Lingua Italiana, Principe Mario Chigi. Nel 1884 il Corpo Militare aveva dato lčavvio allčallestimento dei materiali occorrenti: una "Baracca Ospedale", i primi ospedali mobili, e quattro Treni Ospedale. Siamo agli esordi. I mezzi sanitari sono pressoché inestistenti eppure è necessario realizzare adeguati supporti per assolvere il compito assegnato in caso guerra. Nasce così nel 1884 la "Baracca Ospedale", un vero e proprio ospedale, realizzato in legno e tela impermeabile. Componibile senza schema fisso, con vasta sala di accettazione, locali di uso generale, sale operatorie, la farmacia, una degenza Sottufficiali e Truppa per 110 posti letto, un reparto per i malati più gravi, una degenza riservata agli Ufficiali, con un sistema di aereazione e riscaldamento modernissimi per lčepoca. Allčesterno della Baracca, in baracche separate, una sala di isolamento, il reparto disinfezione e lavanderia, magazzini vari, una Cappella e una sala mortuaria. La "Baracca Ospedale", vera e propria opera ingegneristica, viene esposta al pubblico nel piazzale della Caserma MACAO in via Castro Pretorio in Roma. Sempre nel 1884 la Baracca Ospedale viene impiegata nelle manovre del I Corpo dčArmata nel Novarese. È il primo contatto tra l'Associazione dei Cavalieri e lčEsercito Italiano. Lčesperimento fu estremamente positivo e diede inizio ad una collaborazione veramente sentita e che è ancora in atto.
Intanto entrano in servizio anche i primi ospedali mobili da 50 posti letto, trasportabili ciascuno su 25 muli. In genere vengono installati allč interno di fabbricati. E finalmente nel 1886 entrano in servizio 4 treni ospedali da 280 posti ciascuno. Nel dicembre del 1908 il terremoto Calabro-Siculo è il vero banco di prova per il Corpo Militare che, nella circostanza, impiega tutti i suoi mezzi sanitari. Nella circostanza viene decretato che, fermo restando il compito precipuo di assistere lčesercito in guerra, il Corpo Militare può intervenire anche nei casi di pubbliche calamità. Nel 1909 il Corpo Militare diventa Corpo Speciale dellčEsercito Italiano e adotta lčuniforme grigioverde e le stellette. Nel 1911-12, in occasione della guerra di Libia, al Corpo viene assegnata in dotazione la Nave "Regina Margherita", subito trasformata dal personale del Corpo stesso in ospedale galleggiante. NAVE Vengono effettuate complessivamente sette viaggi raggiungendo da Napoli e da Palermo i porti di Tripoli, Bengasi, Derna e Tobruk, trasportando e curando a bordo 1162 feriti e malati. Per lčopera svolta durante la Guerra di Libia, il Corpo riceve alti riconoscimenti delle autorità governative. Dopo un breve periodo di pace nel 1915 lčEsercito si mobilita per la 1a Guerra Mondiale e con esso il Corpo Militare. Vengono approntati immediatamente quattro Treni Ospedale, otto Posti di Soccorso, un Ospedale da Campo, un Ospedale Territoriale a Roma. Dal 1916, durante le battaglie dellčIsonzo e la disfatta di Caporetto del 1917, i Treni Ospedale vengono messi a disposizione del Comando della 3a Armata. I Treni in pratica saranno dei veri e propri Ospedali viaggianti per la lunga durata dei trasferimenti dovuta a soste per interruzioni e bombardamenti. In quattro stazioni - Roma, Bologna, Milano e Padova - vengono realizzati grandi magazzini, ciascuno diviso in quattro settori quanti erano i Treni. Per ciascun Treno capienti scaffali contenevano il ricambio della biancheria e degli effetti "letterecci", prodotti farmaceutici, disinfettanti, viveri e attrezzature sanitarie.
Complessivamente i quattro treni trasporteranno dai vari fronti agli Ospedali Territoriali distribuiti nel territorio nazionale ben 448.000 infermi, percorrendo 560.000 KM. per un complesso di 641 viaggi. Gli otto Posti di Soccorso furono dislocati a ridosso del fronte a Gemona - Casarza - Montebelluna - Cormons - Ala Avio - Castelfranco Veneto - Monselice - (poi a Monfalcone e Trieste), ed erano costituiti ciascuno da 1 Ufficiale Medico e 12 Sottufficiali infermieri. Inizialmente ebbero il compito di prestare solo soccorsi di urgenza nei pressi delle stazioni ferroviarie, ma successivamente per le sempre più pressanti esigenze di questa lunga, estenuante guerra, diventarono veri e propri ospedaletti da campo che, adeguatamente potenziati, fornirono assistenza anche alla popolazione civile. Complessivamente gli otto Posti di Soccorso praticarono oltre 87.000 prestazioni a militari e civili. LčOspedale da campo da 100 letti venne impiantato vicino a Cividale del Friuli, in un antico castello semidiroccato dei Vescovi di Aquileia, restaurato per lčoccasione dallčAssociazione dei Cavalieri Italiani dellčOrdine. Durante la ritirata di Caporetto, lčOspedale fu sgomberato su Udine. Complessivamente fornì 20.000 prestazioni.
Il Corpo Militare impiantò infine lčOspedale Santa Marta in Roma, (Ospedale Pontificio, messo a disposizione dellčOrdine da Sua Santità Benedetto XV), capace di 350 posti letto e fornì 5.000 prestazioni offrendo agli infermi quanto la scienza poteva consentire. Questa lčopera del Corpo Militare durante i quattro anni della 1a Guerra Mondiale, al termine della quale, lo Stendardo del Corpo venne decorato con una Croce di Guerra al Valor Militare e una Croce di Guerra al Merito "per le prove continue di abnegazione, di ardire e di alto senso del dovere sempre e dovunque dimostrate". Seguirono i riconoscimenti delle più alte Autorità Governative e dei Sindaci dei territori in cui il Corpo si era prodigato. Dopo un periodo di tranquillità di oltre venti anni il 10 giugno 1940, scoppiata la 2a Guerra Mondiale, il Corpo Militare mobilita nuovamente i suoi reparti ed interviene ancora a fianco della Sanità Militare. Entrano in servizio tre treni ospedale naturalmente più moderni che effettueranno numerosi e lunghi viaggi, arrivando fino in Germania, in Russia, in Albania e in Croazia e in Francia.
Un solo treno ospedale, il IV, riporta dalla Russia ben 24.500 feriti, malati o congelati. A bordo del treno vengono eseguiti molteplici interventi chirurgici, soprattutto nei confronti dei colpiti da congelamento. Il treno raggiunge varie località a ridosso del fronte russo; in particolare Karkoff dove già opera un grande ospedale da campo. Inoltre a Leopoli si impianta un Ospedale da campo che erogherà prestazioni sanitarie a 2.714 militari. In aggiunta vengono allestiti due Ospedali Territoriali: il "Principe di Piemonte" a Roma con 250 posti letto che assicurerà un totale di 188.589 giornate di degenza e il "Principessa di Piemonte" a Napoli con 350 posti letto che assorbirà un totale di 200.000 giornate di degenza. Presso lčOspedale "Principe di Piemonte" di Roma viene istituito il Corpo delle Infermiere Volontarie costituito da una direttrice e 40 infermiere, dame dellčOrdine. Viene inoltre data vita, in Roma, alla "Casa Maria Beatrice" che, prima istituzione del genere, raccoglie i bambini non vedenti e grandi mutilati i guerra. Vengono contemporaneamente allestiti sette Posti di Soccorso di notevoli dimensioni che funzioneranno a pieno ritmo nel corso dei bombardamenti, soccorrendo migliaia di feriti. Viene attivato lčOspedale dellčOrdine di Malta a Roma in un antico Palazzo del Cinquecento. Di notevoli dimensioni, dispone di due sale operatorie e numerosi reparti di degenza. Un Ospedale viene anche aperto in una palazzina allčinterno del Quirinale. Durante la guerra si giunge ad avere operativi 19 Ospedali Territoriali tutti serviti dallčACISMOM sparsi sul territorio nazionale.
Molti Ufficiali, Sottufficiali e soldati del Corpo, anche durante la 2a Guerra Mondiale, cadono sotto bombardamenti aerei e tiri dčartiglieria, alcuni vengono fatti prigionieri e condotti nei campi di concentramento della Germania, altri muoiono per malattia contratta sui treni o nei posti di Soccorso. Lo Stendardo del Corpo Militare per lčopera prestata e per gli atti di valore compiuti durante la 2a guerra Mondiale viene decorato sul campo di una Medaglia dčArgento e di una Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Al termine della guerra inizia lčattività di ricovero e cura dei reduci della prigionia. Per questa esigenza vengono allestiti 18 Ospedali Territoriali con la disponibilità complessiva di 5.485 posti letto, che resteranno in funzione fino al 1961. Subito dopo lčArmistizio, vengono assegnati al Corpo 39 aerei Savoia-Marchetti che saranno utilizzati per ogni tipo di emergenza interverranno anche in occasione del terremoto di Agadir e in altre pubbliche calamità a livello nazionale, tra cui il Polesine. Dalla fine della 2a Guerra Mondiale il Corpo Militare si dedica essenzialmente alle pubbliche calamità ed è presente a Tuscania, in Friuli, ancora nel Polesine, in Campania e in Piemonte. Il 25 novembre 1998 è stato inaugurato il Treno Sanitario di nuova concezione, così composto: - quattro carrozze contenenti tutte le apparecchiature diagnostiche in grado di eseguire un check-up completo; - una carrozza chirurgica di pronto intervento; - una carrozza day-hospital per brevissimi ricoveri in vista di un rapido sgombero su ospedali territoriali, a mezzo di autombulanza ed elicotteri; - una carrozza generatore di corrente; - una carrozza magazzino. Allčoccorrenza, al treno potranno essere aggiunte, con un preavviso di 48 ore, carrozze cuccetta da 36 posti ciascuna. Ciò consentirebbe di avere un treno snello e modulabile a seconda delle necessità. Lo Stato Maggiore dellčEsercito ha assegnato al Corpo Militare unčautocolonna sanitaria la quale dispone di: - un automezzo da ricognizione VM/90 FIAT/IVECO 4X4 - autocarri medi FIAT 4X4 - shelters PIAGGIO, ciascuno montato su autocarro; Allčinterno di ciascuno shelter è in via di sistemazione un ambulatorio: chirurgia dčurgenza; ortopedia; cardiologia; pediatria; ginecologia; otorino; oculistica. Lčintero complesso è da ritenersi unčaliquota di centro sanitario da inserire in un centro logistico pre-costituito nazionale o NATO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|