(Rivista Internazionale - Dicembre 1996: Vie di pellegrinaggio e Ordine di Malta - 1/2)
Storia
Vie di Pellegrinaggio e Ordine di Malta
Paolo Caucci von Saucken
Nato in Palestina in funzione dell’Assistenza e della difesa dei pellegrini, l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme estese rapidamente questa sua vocazione, non solo nei confronti di coloro che venivano in Terrasanta, ma verso chiunque peregrinava ad uno dei santuari maggiori della Cristianità. Sia J. Riley Smith che A. Luttrell hanno sottolineato come nel 1113, e cioè nell’anno in cui Pasquale II riconosce formalmente l’Ordine, questo gestiva già ospizi ad Asti, nei pressi dei valichi alpini e nei porti di Pisa, Bari, Otranto, Taranto e Messina. Così come le sedi di quattro priorati italiani furono situate fin dall’inizio nei punti nodali dei contatti tra l’Italia e la Terrasanta e cioè a Venezia, Pisa, Barletta e Messina.
Appare, quindi, evidente che l’espansione dell’Ordine di San Giovanni, in occidente, in quello che dal punto di vista gerosolimitano e rodiota veniva chiamato, in una inversione di prospettive, ultramare, privilegia le vie di comunicazione, i porti, i valichi ed i nodi stradali. Certamente questo avviene per agevolare i collegamenti verso i luoghi dove era più intensa ed impegnativa l’attività dell’Ordine, ma anche per espletare quella naturale vocazione all’assistenza dei pellegrini che si rivolgeva a grandi masse di persone in continuo movimento verso i luoghi santi della Cristianità.
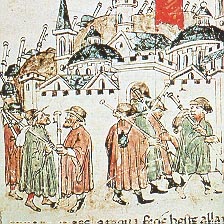 |
Pellegrini del Giubileo del 1300. Miniatura dalla Cronica (Scarambi, Ms. 107). |
Per stabilire il rapporto organico tra Ordine di Malta e vie di pellegrinaggio e per valutare il senso, il valore e le prospettive nella grande stagione di rinnovati pellegrinaggi che la fine del nostro millennio annuncia, è necessario innanzitutto stabilire in che cosa consista una via di pellegrinaggio medievale, come si articola, quali sono le sue caratteristiche e, soprattutto, come è possibile individuarla e ricostruirla ai nostri giorni.
Gli elementi che indicheremo sono, oltre che memoria storica ed archeologica utile alla definizione di una via di pellegrinaggio, anche indicazione dei fattori da valorizzare nella prospettiva di un suo recupero in funzione del prossimo giubileo romano del Duemila.
Per definire una via di pellegrinaggio, quindi, abbiamo vari criteri. Innanzitutto questa via deve avere come meta un importante luogo di culto. La prima considerazione da fare è, infatti, che l’itinerario deve essere funzionale al raggiungimento della meta che costituisce il punto di riferimento costante e che orienta e dà il senso a tutto quello che avviene lungo di esso.
Il santuario stesso o il luogo di culto che si vuole raggiungere dà, inoltre, frequentemente il nome al percorso che vi porta; abbiamo così vie lauretane, vie micaeliche e vie romee. Il caso più noto e dalle caratteristiche esemplari è costituito senz’altro dal Camino de Santiago, che pur essendo anche via commerciale e militare prende il nome dalla sua funzione più specifica che è quella di condurre i pellegrini al sepolcro dell’apostolo Giacomo rinvenuto in Galizia, nella parte più estrema del mondo medievale allora conosciuto, in occasum mundi, o in finibus terrae, come leggiamo nei testi medievali.
per continuare
per tornare al sommario